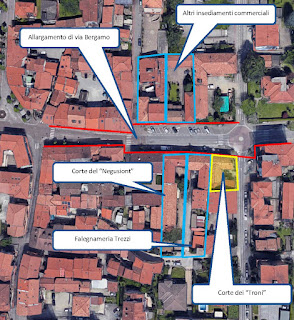Scuola e didattica a distanza
C’è un ragionamento sulla scuola che è maggioritario nell’opinione
pubblica e che è stato anche uno slogan molto presente nelle manifestazioni dei
giorni scorsi: che il lavoro fatto nella fase della Didattica A Distanza (DAD) non
sia scuola. Affermazione che trovo offensiva rispetto ai tantissimi insegnanti
che hanno lavorato anche di più di quanto avveniva nella Didattica In Presenza,
tra chi già si era cimentato di suo nell’uso TIC per fare didattica e chi ci si
è buttato improvvisando e imparando in fretta ad utilizzare questi strumenti.
Si sono commessi errori in questa attività? Probabilmente tanti (solo pochi
hanno il coraggio di autoassolversi del lavoro fatto in questi mesi in tutti i
campi), è normale in una fase di emergenza; (affascinante anche i diversi
significati che la parola emergenza ha nella lingua italiana, ma andrei fuori
tema). L’errore più vistoso è stato quello di pensare di replicare la strumentazione
della didattica in presenza a quella a distanza, compresa la valutazione.
Errore d’impostazione che si rischia di ripetere anche per la ripresa a
settembre. La mancanza di competenze diffuse, nonostante gli investimenti degli
scorsi anni sulla formazione in questo senso, tra insegnanti e dirigenti, ha portato
spesso a non capire quali fossero le potenzialità e i limiti della DAD (ma
anche della didattica in presenza), a partire dalla differenza che si può fare
tra la Formazione A Distanza e l’e-learning; dove nel secondo caso diventa
centrale l’interazione sia con gli strumenti didattici che tra gli studenti.
I dati raccolti in tempo reale mettono in evidenza un
problema di forte divaricazione tra gli studenti in merito alle condizioni
domestiche, alle disparità territoriali sulla infrastruttura della connessione
(due aspetti su cui la scuola non ha molti strumenti d’intervento) la mancanza
di competenze digitali e di strumenti individuali adeguati, aspetti su cui invece
la scuola può fare qualcosa di più. Sull’ultimo punto della strumentazione però
dovremmo metterci d’accordo, fino a poco prima della chiusura sembrava che il
problema fosse esattamente l’opposto con ministri che scrivevano circolare in
cui non solo vietavano l’uso di cellulari e tablet a scuola, ma addirittura il
possesso di questi strumenti; scuole che integravano l’arredo dell’aula con
apposito armadietto in cui chiudere a chiave i cellulari degli studenti,
lamentando l’eccessiva invasione di questi strumenti.
L’emergenza sanitaria ha richiesto la chiusura fisica delle
scuole a cui si è cercato di sopperire con una strumentazione diversa che
richiede una didattica diversa meno trasmissiva e più attiva e collaborativa da
parte degli studenti, diversificata anche rispetto all’età degli studenti
stessi. Ho l’impressione (solo questa per ora) che gli errori più vistosi li
abbiamo fatti con gli studenti più grandi, quelli con cui potenzialmente è
possibile una maggiore applicazione delle potenzialità delle TIC, rispetto agli
ordini scolatici del primo grado in cui la didattica attiva e collaborative era
già più presente prima della chiusura, come già ribadito da più parti il
problema prioritario è la didattica rispetto alla strumentazione.
Ritengo che la DAD sia stata comunque scuola, una scuola
diversa e che spero sia in grado di fornire apporti interessanti anche alla
didattica in presenza da settembre, confidando che l’epidemia sia ridotta entro
limiti di rischi accettabili per ridurre il distanziamento sociale. E’ stata
più scuola ad esempio dell’idea di ricominciare la (didattica?) in presenza per
una settimana o per fare la festa di fine anno.
Che l’e-learning sia una possibilità con cui misurarsi nella
didattica quotidiana lo si può vedere, anche limitandoci all’ambito formativo,
alla sviluppo che stanno avendo le università on line, ai MOOC che tutte le
principali università e centri di formazione stanno proponendo in un ottica di
life long learning, alla fortuna anche economica che hanno avuto esperienze
come quelle della Khan Academy o altre forse meno famose ma molto utilizzate
dai nostri studenti come la pagina youtube di Elio Bombardelli (non solo
influencer quindi), o anche ancora più modestamente la mia pagina che ha ora
730 iscritti (quasi tutti non sono miei studenti, loro accedono ai filmati
dalla piattaforma della scuola senza la necessità di iscriversi).
Grandi innovazioni nel campo dell’e-learning sono state
fatte da alcune case editrici, dalla Zanichelli alla Treccani, ma anche da
altri soggetti dalla RAI, all’archivio Alinari, moltissimi musei in tutto il
mondo.
Si dice che dopo la pandemia non sarà più uguale a prima
(vedremo) per cui sono rimasto perplesso nello scoprire che tra gli slogan
delle manifestazioni scorse ci fosse anche l’avversione contenuta in un
evanescente bozza del MIUR, della possibilità di contemperare l’integrazione
tra DAD e didattica in presenza e anche contro l’affermazione (senza i
conseguenti fatti) della necessità di estendere la formazione degli insegnanti
e stavolta si spera non per una didattica con le TIC ma per una didattica nelle
TIC.
Si dice che la DAD sia priva di una componente fondamentale
della didattica che è la relazione, ora proprio il passaggio dalla Formazione A
Distanza all’e-learning ha come punto centrale l’elemento dell’interattività e
della collaborazione per il raggiungimento del risultato; in cui è importante
il ruolo del tutor per alimentare e tenere vivi gli aspetti relazionali. La
mancanza di coscienza dei diversi ruoli e compiti necessari per attivare una
didattica in e-learning rischia di continuare l’improvvisazione dei mesi
scorsi.
Dovremo anche accordarci sul tipo di relazione, di empatia e
di benessere che la scuola (secondo alcuni psicanalisti comunque un archetipo
paterno) deve assicurare agli studenti, che è centrata sull’apprendimento. Tutta
la passione e anche l’amore che l’insegnante mette nella relazione con lo
studente è focalizzata all’apprendimento in quanto crescita, essendo relazione
può anche non essere condivisa, ma in quanto professionisti della formazione
tocca a noi insegnanti capire come impostare il lavoro.